Nel 2013, quando tablet e smartphone iniziavano a ridefinire le nostre abitudini quotidiane, il filosofo Roberto Casati pubblicava un saggio agile e provocatorio: “Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere”. Un titolo che suonava come un manifesto, un avvertimento contro la colonizzazione subdola delle nostre menti e, soprattutto, delle nostre pratiche di lettura e apprendimento da parte di un digitale allora emergente ma già pervasivo. A più di un decennio di distanza, nell’iperconnesso 2025, dominato da un’intelligenza artificiale sempre più sofisticata e da dibattiti pedagogici e psicologici che cercano di tenere il passo con l’innovazione, vale la pena riaprire quelle pagine. Le “istruzioni” di Casati sono ancora una bussola valida o il paesaggio è mutato al punto da renderle obsolete?
Le Profetiche Intuizioni di Casati: Ecosistemi e Attenzione Rubata
Il cuore della critica di Casati non era un luddismo antitecnologico, ma una profonda riflessione sul cambiamento degli “ecosistemi” della conoscenza e della lettura. Con lucidità, analizzava come il libro cartaceo, con la sua linearità e capacità di “occupare gelosamente il nostro tempo”, rappresentasse un ambiente cognitivo quasi perfetto per la lettura approfondita, specialmente per i saggi.
Casati metteva in guardia contro la transizione acritica al digitale, non tanto per una presunta inferiorità intrinseca dell’ebook – su cui inizialmente aveva espresso dubbi legati più alla sua funzione sociale che alla tecnologia in sé – quanto per l’avvento di dispositivi multifunzione come l’iPad. Questi, sosteneva, avrebbero “rubato la lettura”, relegandola a una delle tante app in competizione per la nostra attenzione, una risorsa limitata e costantemente sotto assedio. Usando l’arguta analogia della fotocamera diventata onnipresente grazie al cellulare, Casati prevedeva che la lettura digitale si sarebbe diffusa non per merito proprio, ma perché integrata in gadget acquistati per altre ragioni.
Cruciale nel suo pensiero era la critica al mito dei “nativi digitali”, l’idea che le nuove generazioni possedessero naturalmente un’intelligenza diversa, più adatta al multitasking e alla dispersione. Casati smontava questa nozione, definendola priva di solide basi empiriche, e sottolineava come la scuola dovesse resistere alla “normatività automatica” che spinge ad adottare ogni nuova tecnologia senza un reale progetto pedagogico. Denunciava, inoltre, la “sciatteria progettuale” di molti ambienti digitali, che frammentano l’attenzione e impoveriscono l’interazione con il sapere.
Il 2025: Colonialismo Digitale Avanzato o Nuove Forme di Resistenza?
Oggi, le riflessioni di Casati appaiono non solo attuali, ma per certi versi ancora più urgenti. L’intelligenza artificiale generativa (come gli LLM) e i sistemi di raccomandazione algoritmica hanno aggiunto un nuovo livello di complessità. Se Casati si preoccupava delle “raccomandazioni di Google” che creano bolle informative, oggi queste bolle sono ancora più personalizzate e potenzialmente limitanti. La “delega delle decisioni umane agli algoritmi”, un tema che Floridi ha ampiamente esplorato, si estende ora anche alla curatela dei contenuti e persino alla loro creazione. Il “Maestro Elettrico” preconizzato da Casati potrebbe oggi assumere le sembianze di un tutor AI, con tutte le incognite pedagogiche che ciò comporta.
La pandemia ha accelerato l’integrazione del digitale nella didattica, spesso in modo emergenziale e non sempre critico. Tuttavia, si assiste anche a una crescente consapevolezza sulla necessità di educare al pensiero critico negli ambienti digitali, alla media literacy e a un uso equilibrato delle tecnologie. Le idee di Casati sul “design del tempo” e dello “spazio” per l’apprendimento, come il “mese della lettura” o le “biblioteche personalizzate”, offrono spunti preziosi per ripensare contesti educativi che proteggano la concentrazione e l’approfondimento, anche nell’era dell’apprendimento ibrido e delle piattaforme online. La sua critica ai manuali scolastici autoprodotti in modo acritico tramite “mash-up” risuona forte oggi, quando la facilità di accesso ai contenuti online può portare a una superficiale collazione di informazioni piuttosto che a una vera costruzione di conoscenza.
La ricerca psicologica contemporanea continua a confermare i timori di Casati sugli effetti del multitasking e dell’esposizione costante a stimoli digitali sulla capacità di attenzione sostenuta e sulla memoria di lavoro. La “sindrome da intrappolamento”, ovvero il restare confinati nelle proprie bolle di conferma, è un fenomeno ben studiato e riconosciuto come un rischio per il benessere individuale e la coesione sociale. La distinzione tra leggere su carta e su schermo continua ad essere oggetto di studio, con evidenze che spesso indicano vantaggi per la carta in termini di comprensione profonda e memorizzazione, proprio come suggerito dalle riflessioni di Casati sui vantaggi cognitivi del libro fisico.
Le “Istruzioni per continuare a leggere”: una guida per il presente
Le “istruzioni” di Casati, disseminate lungo tutto il saggio, non sono ricette semplicistiche, ma inviti a un’azione consapevole e a un ripensamento critico:
- Difendere gli spazi e i tempi della lettura: L’idea di “percorsi di lettura protetta”, sia a scuola che in famiglia, e di un design istituzionale che valorizzi la lettura (come biblioteche scolastiche aperte e accoglienti, o il prestito massiccio di libri ) è fondamentale per contrastare la frammentazione dell’attenzione.
- Resistere alla “normatività automatica”: Non ogni novità tecnologica è intrinsecamente un progresso, specialmente in ambito educativo. La scuola, come suggerisce Casati, dovrebbe essere un luogo di “inerzia” critica, capace di valutare le tecnologie invece di subirle.
- Sviluppare competenza tecnologica critica: Invece di accettare passivamente i “nativi digitali”, la scuola dovrebbe educare alla comprensione del funzionamento delle tecnologie, degli algoritmi, delle logiche di potere e commerciali che le sottendono (come nel caso di Wikipedia, che invita a non “fare la guerra” ma a contribuire criticamente ).
- Promuovere il “design” consapevole: Il design delle interfacce, degli ambienti di apprendimento e delle stesse tecnologie digitali è cruciale. Casati invoca un design che protegga l’attenzione e favorisca l’approfondimento, invece di incentivare la dispersione.
- Usare il caso per rompere le bolle: L’intuizione di usare strategie aleatorie per sfuggire ai filtri di personalizzazione è un piccolo ma significativo atto di resistenza cognitiva.
Oltre il colonialismo, verso una cittadinanza digitale attiva
“Contro il colonialismo digitale” di Roberto Casati, letto oggi, non ha perso nulla della sua forza polemica e della sua lucidità analitica. Anzi, in un mondo dove l’IA promette di automatizzare ulteriormente il pensiero e la fruizione culturale, le sue riflessioni sulla difesa dell’attenzione, sulla valorizzazione della lettura profonda e sulla necessità di un approccio critico e progettuale alla tecnologia sono più vitali che mai.
Il “colonialismo digitale” forse ha affinato le sue armi, rendendosi più invisibile e seducente attraverso algoritmi intelligenti e interfacce personalizzate. Ma le “istruzioni per continuare a leggere” – e, per estensione, per continuare a pensare criticamente – offerte da Casati rimangono una guida preziosa. Non si tratta di rifiutare il digitale, ma di abitarlo con consapevolezza, negoziando i suoi strumenti, mettendo in discussione le sue logiche e, soprattutto, progettando attivamente gli spazi e i tempi per coltivare ancora quella “montagna incantata” di libri e di pensiero che l’autore evocava all’inizio del suo viaggio. La sfida, oggi come allora, è quella di non essere semplici consumatori passivi di un ambiente digitale preconfezionato, ma cittadini attivi e designer consapevoli della nostra infosfera.
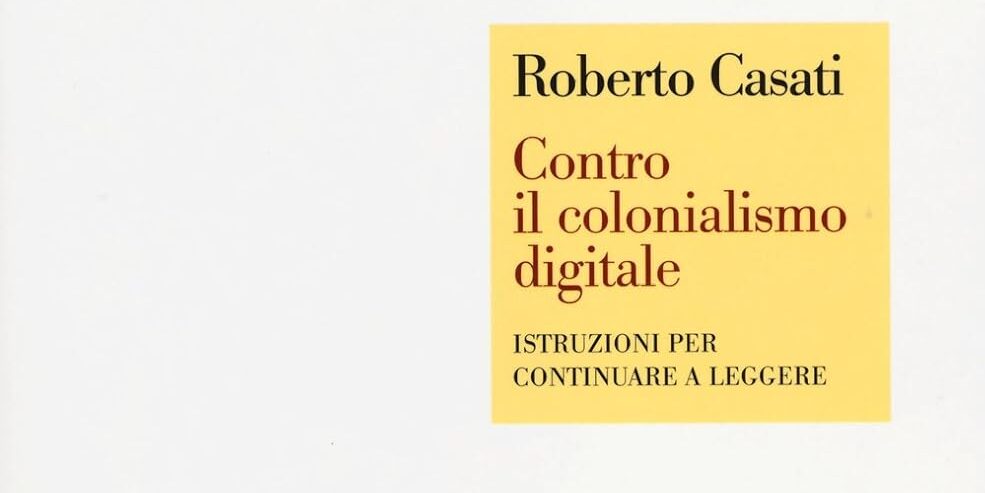
 using WordPress and
using WordPress and
Comments are closed